Di Pierre Coppi
L’Estetica dell’Abisso nei Videogiochi: Una disamina sul parallelismo tra letteratura horror e il mondo videoludico.
L’Oltre-Gioco: Quando l’Estetica Vince sulla Meccanica
Esiste un momento, nella vita di ogni videogiocatore consapevole, in cui ci si rende conto che la perfezione tecnica non è tutto. Anzi, a volte è proprio l’imperfezione, o per meglio dire la deviazione dalla norma, a rendere un’opera immortale e capace di incidersi a fuoco nella memoria collettiva. Nel lontano 1757, il filosofo Edmund Burke teorizzava il concetto di Sublime: “un’emozione totalizzante che nasce dal terrore, dalla vastità incommensurabile e dall’oscurità più insondabile, capace di schiacciare l’animo umano sotto un peso tanto spaventoso quanto irresistibilmente affascinante“. Il Sublime non rassicura, non coccola lo spettatore; al contrario, lo pone di fronte alla propria finitezza, costringendolo a contemplare l’abisso.

Oggi, a secoli di distanza dalle speculazioni estetiche del romanticismo, quel Sublime lo ritroviamo rielaborato e codificato nei pixel. Lo ritroviamo in titoli che, paradossalmente, vengono spesso liquidati in modo superficiale come mediocri per via di un gameplay zoppicante, di collisioni non calcolate alla perfezione o di un’intelligenza artificiale non all’altezza degli standard tripla A contemporanei. Ma chi ha vissuto un’esperienza come Clive Barker’s Jericho sa esattamente di cosa stiamo parlando. Se analizzato con il freddo e spietato rigore del tester del controllo qualità, Jericho è uno sparatutto profondamente imperfetto, legnoso e a tratti frustrante. Eppure, se abbandoniamo la pretesa della funzionalità ludica e lo guardiamo con gli occhi della fame estetica, ci troviamo davanti a un affresco visivo monumentale.
Quando la meccanica fallisce o si ritira in secondo piano, l’estetica prende il comando assoluto della nave. L’illuminazione, la geometria degli spazi, il design delle aberrazioni e la densità dell’atmosfera diventano il vero e unico motore dell’esperienza. Questo speciale nasce proprio per esplorare le radici profonde di questo orrore artistico, analizzando con lente d’ingrandimento come i padri nobili e indiscussi del genere macabro e fantastico abbiano plasmato, in modo diretto o sotterraneo, i nostri incubi digitali. Indagheremo l’impronta stilistica di Barker, Giger, Lovecraft, Stoker e Poe, decodificando come la loro poetica sia sopravvissuta alla transizione dalla carta e dalla tela fino al codice binario dei mondi virtuali in tre dimensioni.
I. Il Biomistico: Clive Barker e la Liturgia della Carne

Per comprendere appieno la monumentale eredità di Clive Barker all’interno del medium videoludico, dobbiamo compiere un atto di sovversione intellettuale: dobbiamo scardinare il concetto puritano, quasi fiabesco, di mostro e abbracciare senza riserve quello di visionario e di martire. Per Barker, l’orrore non nasce mai dal male puro inteso come banale e manichea, schematica, assenza di bene, e tantomeno dalla semplice volontà di distruzione. L’orrore barkeriano nasce dalla trasformazione, dall’esplorazione dei limiti estremi della percezione umana attraverso il medium più universale che esista: il corpo. Il suo è un approccio che possiamo e dobbiamo definire Biomistico. Si tratta di una fusione febbrile, quasi allucinatoria, tra la biologia più cruda, fatta di fluidi e tessuti lacerati, e una spiritualità deviata, oscura, dove la carne diventa l’unico vero sacramento possibile e il dolore si fa veicolo di ascensione.
In opere seminali per il game design atmosferico come Jericho o l’indimenticato Undying, l’architettura stessa dei livelli rispecchia questa filosofia. Il corpo umano, e per estensione l’ambiente che lo circonda, non è un tempio inviolabile da proteggere dalla corruzione, ma una materia prima duttile, pronta per essere scolpita, aperta e riassemblata. Barker ci insegna, con una ferocia visiva senza pari, che la bellezza può risiedere nella ferita aperta, nello scorticamento sistematico che rivela la verità pulsante sottostante la maschera della pelle.
I suoi nemici digitali non sono mai semplici ostacoli da abbattere per accumulare un punteggio o proseguire nel livello. Sono esploratori di una sofferenza che eleva lo spirito, monaci di un ordine grottesco che hanno trovato l’illuminazione attraverso la mutilazione. Pensiamo ai guerrieri romani di Al-Khali in Jericho: non stiamo affrontando banali zombie rianimati dalla negromanzia da quattro soldi. Affrontiamo esseri che si sono fusi con le proprie armature arrugginite in un eterno, solenne rituale di dolore e ferro. In loro, la pelle mortale, i tendini e il metallo forgiato hanno smesso di essere entità distinte secoli prima che il giocatore premesse il grilletto, diventando un unico organismo teologico.

L’estetica di Barker, tradotta nei motori grafici, rifiuta categoricamente il concetto di pulito o di asettico. I livelli barkeriani grondano. Ogni superficie deve essere umida, riflettente di fluidi corporei o sangue coagulato, e ogni effetto sonoro deve essere viscerale, studiato per richiamare alla mente del giocatore lo strappo dei tessuti, il rumore di ossa che si spezzano sotto pressione o il respiro rantolante di gole recise. Mentre l’horror generico e commerciale usa furbescamente il buio totale per nascondere i propri limiti tecnici, le mancanze narrative o per facilitare un banale jump scare, l’orrore barkeriano fa l’esatto opposto: usa la luce. Usa un’illuminazione teatrale, quasi caravaggesca, per mostrare con orgoglio ogni singolo nervo scoperto, ogni tendine teso allo spasimo, ogni mutazione anatomica.
È un orrore caldo, pulsante, febbrile, che odora di rame e incenso. Sfida costantemente l’utente a trovare il senso del sacro all’interno del profano più inaccettabile. In questo universo stilistico, il dolore inflitto o subito non è mai fine a se stesso. Non è una punizione per un peccato, ma è il pedaggio obbligatorio, il prezzo necessario per ottenere un’epifania sensoriale che trascende la freddezza del codice binario per colpire direttamente il sistema nervoso del giocatore, provocando un disagio che è, al tempo stesso, repulsione e perversa fascinazione.
II. Il Biomeccanico: H.R. Giger e la Genesi Industriale Assoluta

Se Clive Barker rappresenta il calore del sangue che scorre impetuoso e la devozione quasi religiosa verso la carne, l’artista svizzero H.R. Giger incarna il polo opposto dello spettro estetico: il gelo assoluto e letale del metallo che penetra la cellula vivente, violandola senza alcuna traccia di passione, odio o sadismo. Giger ha introdotto e perfezionato la vertiginosa visione del Biomeccanico, un universo claustrofobico in cui la millenaria distinzione tra l’elemento naturale e il costrutto artificiale svanisce completamente, inghiottita in un incubo aerografato fatto di infinite scale di grigi, neri profondi e toni seppia malati. In questo mondo, la vita non sboccia, non nasce: viene letteralmente fabbricata in catena di montaggio.
L’immensa influenza di Giger nel game design e nella direzione artistica moderna ha toccato il suo vertice assoluto, quasi filologico, con Scorn, ma la sua ombra lunga permea l’industria fin dall’alba dei mondi tridimensionali. Nel cosmo visivo gigeriano, l’alienazione dello spettatore è totale, oppressiva e senza vie di scampo. Non c’è narrazione verbale a cui aggrapparsi, non ci sono dialoghi esplicativi, non ci sono alleati. C’è solo un’architettura soverchiante che respira, pulsa lentamente e ci osserva con un’indifferenza che fa raggelare il sangue.

Le strutture che esploriamo in queste incarnazioni ludiche non sono edifici: sono interiora pietrificate. Le porte sono sfinteri muscolari che si contraggono e si dilatano con rumori umidi; le chiavi per sbloccare i percorsi sono grotteschi innesti ossei da strappare via e inserire in terminali composti da cartilagine; le stesse armi che impugniamo non sono strumenti meccanici inerti, ma estensioni parassitarie del sistema nervoso centrale che si agganciano all’ospite, nutrendosi letteralmente di esso per funzionare. È l’apoteosi dell’orrore in cui la funzione industriale si eleva al di sopra di qualsiasi emozione umana. L’estetica di Giger ci immerge in un universo saturo di erotismo macabro e simbolismo psicosessuale, dove ogni tubatura, ogni corridoio e ogni meccanismo rimanda ossessivamente agli atti della copulazione, della procreazione e della nascita. Ma lo fa in un modo così freddo, chirurgico, industriale e privo della benché minima empatia da risultare psicologicamente devastante.
A differenza dell’estetica di Barker, che come abbiamo visto cerca costantemente il divino nascosto nelle pieghe della carne mutilata, i mostri e gli ambienti di Giger non possiedono alcuna teologia. Sono orfani di Dio. Sono nient’altro che funzioni biologiche perfette, supreme macchine di sopravvivenza ed espansione modellate da un’evoluzione mostruosa. La creatura gigeriana per eccellenza, come lo Xenomorfo (Alien, 1979), non prova odio per la razza umana, non prova il piacere della caccia in senso sportivo o sadico; usa semplicemente il corpo umano come un’incubatrice fertile, sfruttandolo con la medesima, glaciale indifferenza con cui una gigantesca pressa idraulica in una fabbrica schiaccia e modella un foglio di metallo.

Nei videogiochi, questa estetica specifica lancia una sfida unica: costringe il giocatore a tentare di sopravvivere all’interno di un ambiente che lo rifiuta a livello molecolare. Il mondo non è malvagio verso l’avatar; semplicemente, non è stato progettato per ospitarlo. L’utente si rende conto di essere un corpo estraneo, un’anomalia in un sistema perfetto, autosufficiente e letale. Qui, l’orrore non scaturisce dal timore della morte fisica, ma dalla consapevolezza raggelante di essere considerati nient’altro che materiale di scarto biologico, oppure un contenitore usa e getta destinato a perpetuare un ingranaggio eterno, silente e mostruosamente indifferente alle lacrime umane.
III. L’Orrore Cosmico: H.P. Lovecraft e la Dissoluzione della Ragione

Spostandoci dal tormento tangibile della carne e dalle geometrie fredde del metallo verso i fragili recessi della mente umana, incontriamo il pilastro più intellettuale, inafferrabile e, purtroppo, più drammaticamente frainteso dell’orrore: Howard Phillips Lovecraft. Il nucleo tematico della poetica lovecraftiana, la sua vera cifra stilistica, non risiede mai nel mostro in sé, inteso come bestia zannuta in agguato nell’ombra. Risiede, piuttosto, nell’insignificanza totale, matematica e cosmica del genere umano di fronte a un universo spaventosamente antico, abitato da divinità mostruose e inconcepibili, per le quali l’intera storia dell’umanità ha meno valore del battito d’ali di un insetto effimero.
Il videogioco moderno, tuttavia, nel tentativo di tradurre visivamente questa disperazione filosofica, ha spessissimo tradito l’essenza stessa dell’opera di Providence. Ha compiuto un atto di riduzione estetica imperdonabile, limitando l’Orrore Cosmico a una mera, pigra questione di direzione artistica superficiale. Abbiamo assistito impotenti alla parata di centinaia di titoli che si sono riempiti di tentacoli viscidi, appendici invertebrate, occhi multipli spalancati e spesse nebbie dalle tonalità violacee, nella radicata e ingenua convinzione che bastasse applicare una patina di viscidume e un design ittico per poter evocare lo spirito di Lovecraft. Si tratta di un errore madornale alla base del game design stesso.

Fornire al giocatore un arsenale pesante, magari un fucile a pompa o un lanciagranate, per permettergli di ingaggiare un combattimento diretto e abbattere un Grande Antico o la sua progenie cosmica significa annientare istantaneamente ogni parvenza di orrore cosmico. La logica è inoppugnabile: se puoi inquadrare l’entità nel tuo mirino, se puoi infliggerle danni quantificabili e, soprattutto, se è dotata di una barra della salute che si svuota, allora quell’entità non è affatto un dio primordiale venuto dalle stelle. È declassato al rango di semplice nemico d’élite, un boss di fine livello come mille altri. Il puro, autentico orrore lovecraftiano risiede esclusivamente nell’impotenza assoluta dell’osservatore, nell’incapacità fisiologica della mente umana di processare le informazioni visive, e non nella potenza di fuoco del suo avatar.
Il vertice indiscusso e insuperato di questa traduzione filosofica nel nostro medium rimane Eternal Darkness: Sanity’s Requiem, proprio perché i suoi creatori hanno compreso un postulato fondamentale: il vero nemico non è la creatura abominevole, ma la percezione stessa della realtà. Il capolavoro di Silicon Knights non si limita a inquadrare e mostrare l’orrore in forma poligonale; mette in scena, letteralmente, la lenta e inesorabile decadenza della ragione umana. Quando nella letteratura macabra evochiamo il tropo dei ratti che si muovono frenetici dietro le pareti, stiamo parlando di un orrore che è insieme architettonico e psicologico, un rumore di fondo che sgretola le certezze basilari dell’esistenza.
“Ho visto l’universo oscuro spalancarsi,
Dove i neri pianeti rotolano senza meta;
Dove rotolano nel loro orrore, inascoltati,
Senza conoscenza, né splendore, né nome.“ — H.P. Lovecraft, Nemesis
Eternal Darkness ha compiuto il miracolo di tradurre il concetto letterario delle geometrie non euclidee compiendo l’unico atto sensato all’interno di un videogioco: frantumando il muro della quarta parete. Simulando cancellazioni di finti salvataggi, abbassando subdolamente il volume del televisore senza alcun input esterno, o inclinando l’inquadratura fino a provocare la nausea, il gioco smetteva di colpire la salute fisica dell’avatar sullo schermo per mirare direttamente alla stabilità e alla sanità mentale del giocatore seduto sul divano. Distruggendo subdolamente la fiducia granitica e cieca che l’utente ripone nel corretto funzionamento del mezzo tecnologico e del software, il titolo prende l’ignoto siderale teorizzato da Lovecraft e lo inietta direttamente nel salotto di casa, trasformando la sessione ludica in un esperimento di gaslighting digitale, manipolando subdolamente il giocatore stesso.
IV. Il Velluto Nero: Bram Stoker e l’Architettura del Sangue Nobile

Se abbandoniamo gli abissi dello spazio e le fabbriche di carne per tornare sulla vecchia terra, incontriamo una dicotomia fondamentale nello sviluppo dell’ambientazione del terrore. Perché molti appassionati che masticano horror videoludico amano in modo così viscerale l’eredità di Bram Stoker? La risposta non si trova nella figura del vampiro in sé, figura ormai declinata in ogni forma possibile, ma risiede nel formidabile peso estetico e nella geniale gestione dello spazio narrativo che l’autore irlandese ha codificato.
Bram Stoker non si è limitato a regalarci la figura immortale del Conte; ha progettato e costruito su carta l’ecosistema perfetto in cui il male deve obbligatoriamente risiedere per potersi ammantare di fascino e carisma. La sua eredità trasposta nel game design si manifesta come un imponente cappotto di velluto nero: è pesante, costoso, denso e avvolgente, quasi soffocante. L’estetica stokeriana è un’opera di stampo monumentale, orgogliosamente barocca e intrisa di un decadentismo spinto all’estremo.
Quando inseriamo il disco di capolavori immortali come Castlevania: Symphony of the Night o quando ci aggiriamo con il fiato sospeso tra le guglie vertiginose e le strade acciottolate di Yharnam in Bloodborne, noi non stiamo semplicemente giocando: stiamo abitando a tutti gli effetti una colossale struttura di matrice stokeriana. In questi mondi, l’orrore non è concepito come un evento improvviso, un’esplosione di violenza casuale o uno scontro fugace in una stanza anonima. L’orrore è, a tutti gli effetti, un luogo geografico preciso, con una sua toponomastica, una sua storia stratificata e un’architettura che lo definisce. Il Castello di Dracula o la cattedrale gotica non sono mai semplici contenitori per i nemici, non sono un banale livello da superare per arrivare ai titoli di coda. Sono organismi enormi, antichi, ecosistemi oscuri che possiedono una loro inequivocabile, perversa nobiltà e un set di regole interne rigorosissime.
“Benvenuto nella mia casa! Entrate liberamente. Andatevene sani e salvi; e lasciate un po’ della felicità che portate!” – Bram Stoker, Dracula
Lo stile stokeriano ci ha insegnato che il mostro di lignaggio superiore ha bisogno di gerarchie sociali, di un’etichetta aristocratica e, soprattutto, di una mappa estesa su cui regnare. Il design dei livelli di stampo gotico nel videogioco si fonda quasi interamente sul senso di smarrimento e successiva padronanza di queste macro-strutture. C’è sempre un sentore palpabile di storia antica, di casate illustri ormai in rovina, di segreti sepolti e rituali profani dimenticati che richiedono pazienza e dedizione per essere svelati. Il giocatore si muove con passo felpato e guardingo attraverso saloni da ballo spettrali le cui vetrate colorate filtrano solo la luce della luna, attraversa biblioteche polverose colme di volumi proibiti e scende in cripte silenziose, sentendo costantemente su di sé il peso gravoso di un passato secolare che minaccia di schiacciarlo.

È un orrore che possiamo definire abitabile, un vasto spazio scenico in cui il macabro, la morte e la resurrezione hanno collaborato per edificare una civiltà pienamente funzionante e retta da leggi spietate. La paura, in questi contesti, non deriva mai dallo spavento improvviso o dallo shock visivo a buon mercato. Deriva dalla solennità opprimente dell’ambiente: noi giocatori siamo intrusi, viandanti e ospiti non graditi in una maestosa corte di predatori immortali, entità che abitavano quelle stanze sfarzose secoli prima che noi premessimo il tasto start, addirittura prima che esistessimo, e che continueranno a banchettare nei secoli a venire. In questo magnifico contesto di decadenza nobiliare, l’estetica stokeriana nobilita il ruolo del giocatore, elevandolo da semplice sterminatore di demoni ad archeologo del sangue. Diventa un esploratore solitario il cui compito non è solo mappare planimetrie complesse e sbloccare scorciatoie, ma portare alla luce e comprendere i peccati originali di una stirpe condannata all’eternità. Puro Romanticismo decadente e irresistibile.
V. La Cocaina: Edgar Allan Poe e la Claustrofobia della Nevrosi

Se Bram Stoker ci prende per mano e ci offre un intero regno tenebroso, lussuoso e affascinante da esplorare, Edgar Allan Poe ci trascina a forza all’interno di una stanza spoglia, chiude la porta a tripla mandata e getta la chiave nel buio. L’influenza estetica e psicologica di Poe sul game design è diametralmente opposta e speculare a quella del romanzo gotico vittoriano: la sua prosa è l’equivalente stilistico di una penna dalla punta acuminata, intinta febbrilmente in un mix letale di inchiostro, caffè nerissimo e cocaina pura. L’estetica di Poe trasposta su schermo è la rappresentazione assoluta dell’orrore confinato al qui e ora. È un’esperienza tachicardica, nevrotica, frastornante, claustrofobica, ossessiva e, sopra ogni altra cosa, totalmente priva di vie d’uscita illusorie.

All’interno dell’orizzonte videoludico, l’eredità immortale dello scrittore di Boston non si concretizza in mappe vaste, castelli tentacolari o panorami nebbiosi da ammirare dalla cima di un campanile, ma la si respira nei corridoi angusti che sembrano stringersi fisicamente attorno alle spalle del nostro avatar. Pensiamo a progetti sconvolgenti come il teaser interattivo P.T., o ai momenti di massima contrazione spaziale in Amnesia e nel capolavoro introspettivo Silent Hill 2. In questi spaccati di puro delirio, viene azzerata totalmente l’eleganza romantica del viaggio e l’ampiezza dell’orizzonte visivo; ciò che resta è solamente l’urgenza spasmodica e disperata di una psiche umana che sta crollando miseramente su se stessa sotto il peso dei propri traumi.
I protagonisti dei titoli di chiara ispirazione poeiana sono figure tragiche per eccellenza: narratori visivamente inaffidabili, individui tormentati, paranoici e quasi invariabilmente intrappolati non tanto da mura di mattoni, da sbarre di ferro o da catene fisiche, quanto dalle prigioni inespugnabili edificate dai loro stessi ricordi repressi, dalle colpe indicibili che hanno sepolto nel subconscio. Edgar Allan Poe ha impartito una lezione durissima ai direttori artistici moderni: ha insegnato che la paura più profonda, quella che paralizza le dita sui comandi, non scaturisce dalla vista di un licantropo furioso o di un vampiro di tre metri armato di artigli. La paura vera e divorante nasce dall’ascolto ossessivo del battito irregolare del proprio stesso cuore, un suono che viene deformato e amplificato in maniera innaturale dal silenzio di piombo di una casa vuota, una casa che sembra ricordare perfettamente, in ogni scricchiolio del legno, tutto ciò di terribile che abbiamo commesso tra le sue mura.
“Perché mai dite che sono folle? La malattia aveva acuito i miei sensi, non li aveva distrutti né ottusi. Soprattutto era diventato acutissimo il senso dell’udito.” — Edgar Allan Poe, Il cuore rivelatore
Questa specifica branca dell’estetica del terrore è la geometria della nevrosi. Ci muoviamo in stanze le cui proporzioni mutano impercettibilmente quando volgiamo lo sguardo altrove, apriamo porte socchiuse che conducono al nulla o in loop temporali impossibili, esaminiamo oggetti della quotidianità più banale che, improvvisamente illuminati da una torcia tremolante, si mettono a raccontare una storia straziante di abusi, follia domestica e omicidi occultati. Se la poetica di Stoker ci regala un orizzonte gotico sconfinato in cui il nostro eroe, per quanto intimorito, possiede l’illusione dell’azione e dello scontro eroico, la poetica di Poe ci schiaccia in un vicolo cieco intriso di claustrofobia, dove l’identità del protagonista sfuma costantemente in quella della vittima sacrificale, costretta alla perenne, angosciante attesa dell’inevitabile. I game designer attingono a piene mani dal pozzo avvelenato di Poe in quelle precise e studiate sezioni in cui intendono strapparci via ogni parvenza di controllo e agenzia. Lo fanno per sussurrarci all’orecchio una verità terribile: l’arma da fuoco che stringi tra le mani virtuali è totalmente inutile, perché il nemico definitivo non striscia in fondo al corridoio. Il nemico è già penetrato dentro la tua testa e siede pazientemente in attesa.
VI. Il Documento Ritrovato: Il Diario come Reperto dell’Abisso
Mettendo da parte le immense sovrastrutture visive forgiate dai singoli autori, esiste una tecnica narrativa trasversale, un fil rouge definitivo ed elegantissimo che unisce in un abbraccio inseparabile l’epoca d’oro della letteratura classica al game design moderno, prettamente spaziale: l’uso del formato documentale. Perché noi giocatori, armati fino ai denti o in fuga disperata per le nostre vite virtuali, sviluppiamo questa urgenza quasi feticistica, questa ossessione compulsiva per la ricerca e la lettura di lettere sgualcite, audiolog crepitanti e diari abbandonati sparsi per i livelli di gioco?
La risposta si trova nel potere umanizzante della parola scritta che si scontra con la freddezza dell’estetica visiva, lo stesso motivo per cui state leggendo questo pezzo invece di stare davanti alla console.
Senza la presenza di un diario a contestualizzarne l’esistenza, un mostro, per quanto eccellentemente modellato, animato con motion capture o illuminato a regola d’arte, rimane fondamentalmente un predatore astratto, un ostacolo meccanico formato da un agglomerato di texture e calcoli matematici. Ma l’introduzione di un diario strappato, sporco di sangue secco e vergato con mano tremante, ed all’improvviso quel mostro assume una dimensione diversa: diventa il tragico punto di arrivo di un dramma umano consumatosi molto tempo prima del nostro arrivo.
Già nel capolavoro assoluto di Stoker, strutturato quasi interamente in forma epistolare e diaristica, i telegrammi, i dispacci e le note cliniche del dottor Seward non sono orpelli testuali, ma strumenti vitali necessari per tentare disperatamente di rendere scientifico, catalogabile e quindi affrontabile ciò che è apertamente impossibile e ontologicamente osceno. Nei polverosi manoscritti lovecraftiani, i diari di spedizioni perdute nei ghiacci antartici o in templi sommersi non spiegano la biologia dei mostri, ma si ergono a testimonianza cronologica di una discesa ineluttabile nella follia, registrando le ultime, sconnesse farneticazioni di uomini che hanno scorto verità che non avrebbero mai dovuto scorgere.
Trasposta all’interno del ritmo frenetico o riflessivo di un videogioco, questa tecnica letteraria ha toccato storicamente il suo vertice concettuale nelle stanze infestate di titoli seminali come Resident Evil. L’ormai leggendario, telegrafico e disturbante diario del custode dell’incrociatore, quello che si conclude con la famigerata sintesi animale “Itchy. Tasty.”, rappresenta lo snodo focale in cui l’orrore cessa brutalmente di essere un elemento puramente visivo, ambientale o di reazione basata sui riflessi, e muta la propria pelle diventando un orrore empatico, letterario, che scava nell’immaginazione.

Fermare la frenesia dell’azione, abbassare le armi e ritagliarsi qualche istante di tregua apparente per leggere i pensieri sfilacciati di coloro che ci hanno preceduto nella dannazione è un vero e proprio atto di intimità proibita. È un voyeurismo macabro, il potente richiamo di un reperto archeologico di immenso valore emotivo. Questa pratica silente e quasi sacrale trasforma quella che potrebbe ridursi a una banale sessione di tiro al bersaglio in un’approfondita indagine forense condotta sul limitare dell’oscurità più insidiosa. Il diario abbandonato sulla scrivania impolverata rappresenta l’ancora di salvezza principale del realismo emotivo: ci rassicura, e al tempo stesso ci terrorizza, confermandoci che in quelle fredde sale poligonali qualcuno ha camminato, ha sperato, ha scritto per lasciare traccia di sé, ed ha sofferto in modo disumano. E la pagina strappata ci avverte, silenziosamente, che seguendo le sue stesse orme scricchiolanti, stiamo inevitabilmente marciando incontro allo stesso identico destino di morte, o peggio. È l’estetica pura del testo scritto che penetra la mente del giocatore lavorando di fino, insinuandosi sottopelle senza il banale ausilio di spettacolari sequenze d’intermezzo preconfezionate o di ingombranti dialoghi esplicativi.
Conclusione: L’Ouroboros del Subconscio

Tirando le fila di questa lunghissima disamina, possiamo affermare con certezza che l’orrore ludico e visivo, in tutte le sue infinite e sfaccettate declinazioni, dalle mutazioni carnali alla freddezza delle macchine industriali, dalle vastità siderali alle pareti domestiche scricchiolanti, non è altro che un gigantesco Ouroboros. È il mitologico serpente cosmico condannato a mordersi la coda in eterno, figurazione perfetta di un ciclo inarrestabile e fecondo di morte simbolica e rinascita culturale. La grande arte visionaria su tela e su carta ispira le righe del codice, il codice strutturato e illuminato spinge il giocatore attento a ricercare la presenza dell’arte in ogni anfratto virtuale, e l’esperienza dell’arte interattiva lo riporta, infine, davanti allo specchio nero dello schermo a riflettere intensamente sulla propria spaventosa e reale vulnerabilità umana.
Sulle pagine di PowerWave83 lo abbiamo sempre saputo, e continueremo a ribadirlo con ostinazione: noi non andiamo alla ricerca di questi giochi spinti dal semplice, infantile bisogno di una scarica di adrenalina a buon mercato, o per farci saltare dalla sedia con trucchi di illusionismo digitale. Noi affrontiamo questi titoli perché siamo assetati di Bellezza. Cerchiamo una bellezza terribile, una grazia estetica che si presenta volutamente deviata, corrotta e perfino tecnicamente claudicante quando misurata con i parametri asettici del mercato mainstream. Eppure, proprio in virtù di questo suo coraggio visionario, essa si dimostra capace di insinuarsi sottopelle e restare impressa nella memoria emotiva per decenni, molto più a lungo, e con molta più forza, di qualsiasi prodotto canonico, levigato, impeccabile nei suoi freddi calcoli fisici, ma irrimediabilmente privo di anima e di tormento. Perché, in definitiva, anche mentre ci ostiniamo a vagare nel buio più profondo e opprimente che il talento umano abbia saputo concepire e programmare, ciò che l’occhio cerca incessantemente è sempre una traccia palpabile di grande stile, un frammento prezioso di puro significato estetico, o, molto più semplicemente, un modo colto ed elegante per trovare il coraggio di mantenere lo sguardo fisso contro l’infinita, terrificante, vastità dell’abisso.



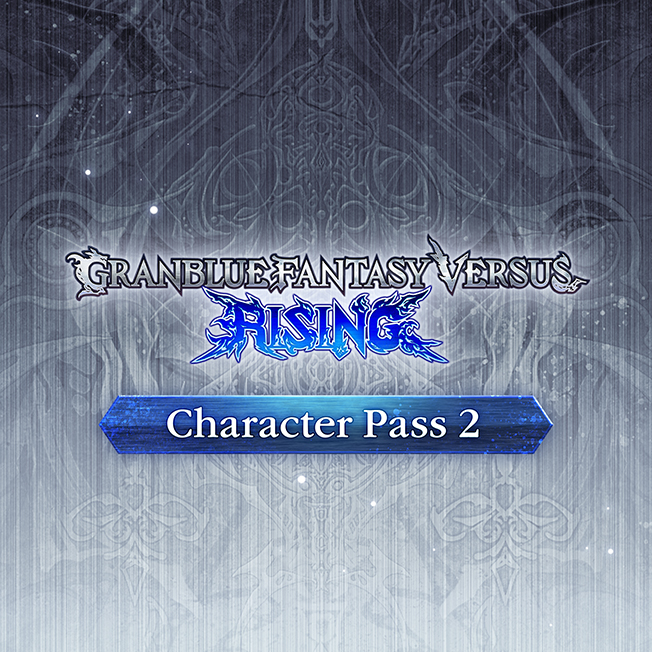
Lascia un commento